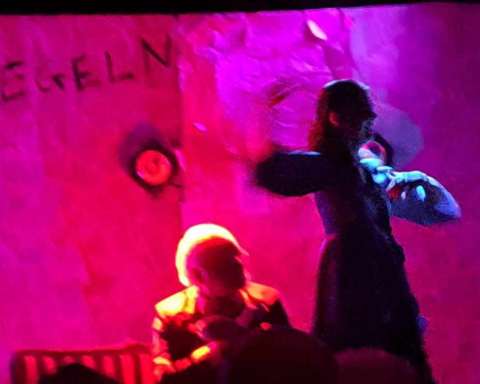Nell’ambito della stagione 2021/2022 del Teatro Elfo Puccini, vi presentiamo la nostra recensione dello spettacolo Malagrazia. L’ideazione e la regia dello spettacolo portano il nome di Giuseppe Isgrò. La drammaturgia è curata da Michelangelo Zeno. I due interpreti dello spettacolo sono Edoardo Barbone e Daniele Fedeli. L’architettura del suono è firmata da Stefano De Ponti. La produzione dello spettacolo è curata da Phoebe Zeitgeist.
L’identità è un percorso doloroso, e la dialettica del servo e padrone, quelle pagine di Hegel, così amate dagli esistenzialisti, sono lì a dimostrarlo. Chi è chi? E, soprattutto, chi fa cosa? Esistere per se stessi è già un atto di autorelegazione. Giuseppe Isgrò tutto questo lo sa bene e, ben aiutato dalla drammaturgia di Michelangelo Zeno, mette in scena la diade perfetta: due fratelli su un’isola in uno spazio chiuso, ridotto di resistenza beckettiano, perfetto laboratorio behaviouristico, dove l’occhio dell’Alex kubrickiano dello spettatore non può fare a meno di guardare. Due esseri, nel tentativo di riconoscersi, si guardano nello specchio dell’altro, ma cadono fatalmente nell’equivoco della mano di Wittgenstein: quello che ritrovano è la propria immagine rovesciata, che è un irriducibile altro da sé. Giocano altri ruoli, prima della fine della partita, si inventano gli ultimi scampoli di identità nei gesti che ossessivamente ripetono.
L‘atto onanistico iniziale è una coazione a ripetere, un rocchetto di Hans e insieme delle Parche, che ossessivamente va avanti e indietro, condannato a riprodurre la stessa sequenza. Il regista ha preso l’aforisma nietzschiano e ne ha fatto una meravigliosa camera sadiana delle torture: “Se fissi un abisso, prima o poi l’abisso scruterà in te”. Un po’ come nella pittura caravaggesca, tutto parte dal nero, da un inevitabile “paint it black” su cui si aprono squarci di luce, sulla carne, ecco il segreto di questa ricetta scenica, luce e carne. La traduzione delle distorsioni pittoriche baconiane, della metamorfosi verso l’assurdo, è qui presente in tutta la sua meravigliosa scomodità; il perturbante, ciò che è più scomodo raccontarsi, e raccontare, il bassoventre che piomba le ali delle più alte aspirazioni, la maschera aristofanesca che fatalmente piega in una smorfia la linea della bocca, e rende assurdo il tragico.
Caino e Abele sono riscritti teatralmente, come se la mano di un Genet si fosse sostituita nella scrittura biblica. L’impossibilità di procreare si sublima nella forma di una perversa creatività. Lo spettacolo è anche un’esperienza sensoriale, olfattiva; l’odore del polpo che bolle, che impone la sua presenza virtuale all’interno della scena e in platea, rappresenta la volontà di parlare, prima di tutto, agli stomaci del pubblico, all’organo meno equivocabile, a quello che misura il mondo dall’istinto atavico della fame. Viene servito come se fosse un cadavere di una tragedia di Seneca, e quei tentacoli raggrumati si prestano a essere l’impossibile parto dei due fratelli, la creatura cronenberghiana, prima tenuta in gestazione attraverso i gesti e le parole dei due personaggi, e poi servita come non essere, come ciò che sarebbe potuto essere. La carne, fatalmente, è sempre in ritardo sul tempo, e la sfida se la giocano ancora le ultime parole.

L’unica soluzione è quella di divorare famelicamente questo essere, come Crono farebbe con i suoi figli, perché il gioco ricominci da capo. Qui, più che un capitano Nemo, c’è la duplicazione del “nemo” latino, ossia del nessuno. E proprio quando l’identità comincia a sgretolarsi, quando i pensieri, le emozioni rinunciano al loro signore delle mosche, al feticcio dei feticci, l’ego, ecco che parla distintamente la voce dell’Altro lacaniano, di un inconscio che si riversa come magma incandescente sulla scena, in una scrittura automatica che non può fare a meno di trascinare gli interpreti e gli spettatori, tutti all’interno di questo buco nero. Non c’è più nemmeno un dumb-waiter, un cordone ombelicale meccanico, pinteriano, che porti notizie di un esterno: tutto si gioca in una stanza chiusa, metafora, insieme spietata ed efficace, della propria carcerazione carnale, esistenziale, e la carica esplosiva del testo scenico si moltiplica esponenzialmente.
Scoppia in faccia a una platea che ha ancora l’odore spirituale della reclusione obbligata, dei lockdown, la sensazione di un esterno che si traduce in pericolo. Edoardo Barbone e Daniele Fedeli sono dei sacerdoti ideali di questo rito dionisiaco, che più scende nella carne e più lacera l’anima. Il loro sudore diventa la testimonianza di uno sforzo di voler trasumanare, diventa il distillato del sangue di un dio impossibile, che cercano, prima di tutto, dentro di sé. Isgrò è fedele alla sua ricerca, al suo interrogativo che suona più o meno così: ”la verità, vi prego, sul dolore”. La crudeltà che ci offre è figlia di quella artaudiana; vuole essere una ricerca senza sconti, condivisa, sull’umano e sul suo senso, non astratta dal gioco mentale, intellettuale, ma vissuta anche e soprattutto nei corpi. SI vive la ricerca di quel corpo ideale di Artaud, mondato dagli organi, eternato, come una mummia egizia, nell’immagine sensoriale dell’eterno.
Ma gli organi diventano gli avversari, gli antagonisti, si tramutano nella dike, nella vendetta divina, cavalli pronti a lacerare l’integrità di un corpo che almeno vorrebbe proclamare il proprio unitario esserci. C’è il travaglio del negativo, certo, ma senza l’happy end di Hegel, nessuna sintesi, nessuna conciliazione. Quello che si può trovare, o meglio pescare, è solo un pesce–uomo, una creatura mitica, deviante dai sentieri della “normalità”, alter ego del regista, raccolto dai protagonisti dalla platea, indossando le maschere della peste. Questo essere inerte è un simbolo esoterico dissacrato e dissacrante, una presenza spiaggiata, come le conchiglie degli esistenzialisti; la vita che non vive e che, ostinatamente, continua a vedere da quell’occhio umido, che guarda oltre la sua possibilità di poter guardare, e lo sguardo dell’altro è ancora lì, ineffabile, amato e odiato, pronto a rilanciare la sfida in un nuovo terribile gioco scenico, buio, applausi.

Se vi è piaciuto questo articolo, vi consigliamo la lettura degli altri che troverete nella sezione teatro e le altre recensioni presenti sul nostro sito. Non dimenticate inoltre di ascoltare il nostro podcast per approfondire i vari aspetti del mondo teatrale.