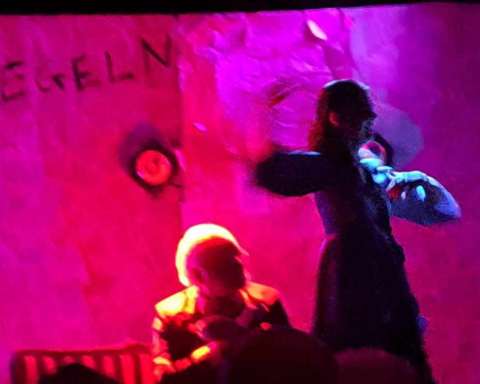Nell’ambito della rassegna digitale Portiamo il teatro a casa tua, ideata e creata da Mariagrazia Innecco, vi presentiamo la nostra recensione dello spettacolo Un atto d’amore, recitato dall’attrice Diana Ceni, e diretto dal regista Alberto Oliva.
Questo lavoro è uno studio liberamente tratto da Anna Cappelli di Annibale Ruccello, un autore che rende la ricetta della tragicommedia un piatto oltremodo gustoso.
Quella che sulla carta sembrerebbe un’impresa utopica, impossibile, sulla scena si realizza, ossia guardare ed ascoltare un’anima senza filtri, vederla in trasparenza come attraverso il bergmaniano uovo di serpente. Quella di Diana Ceni è lì, ben visibile tra i pixel, nei primi piani catturati da quell’invincibile forza di gravità degli occhi, dove si accendono luci che sembrano i fuochi dei bivacchi di un esercito, pronto a dar battaglia e vincere qualunque monologo. L’attrice è letteralmente posseduta del personaggio, è l’eterna Arianna che chiude gli occhi e si lascia fondere e confondere con Bacco, è teurgicamente un tutt’uno con la divinità dionisiaca, e, semplicemente, come nella canzone dei Beatles, lascia che la recitazione sia. Ed il tempo diventa davvero relativo sulla scena, un po’ perché l’anima non ha rughe, un po’ perché la passione teatrale restituisce la verità di quell’istante, di quel momento della gioventù.
È vero perché è vero il sentimento con cui è dichiarato. L’interprete coglie, attraverso la regia di Oliva, che cuce, con un lavoro di alta sartoria il gesto alla parola, tutto lo spirito di un testo che ha il sapore della drammaturgia di Ruccello. Il dramma borghese calza i coturni, e si accorge che quel vertiginoso tacco lo slancia, e gli consente di scendere giù, giù fino agli abissi dell’animo animo. Dietro l’antica skené, dietro la scena possono accadere ancora le cose più oscure e tremende, mentre gli dei se ne stanno lì, nascosti tra un batticarne, un piatto, od un telefono, ad osservare come ogni vendetta venga da sé, con la stessa naturalità con cui si pronuncia un “Buongiorno” od un “Buonasera”. Si racconta una storia d’amore in cui, con buona pace di Fromm, si preferisce di gran lunga avere, possedere, che essere.

Con le lenti di Freud si potrebbe vedere una fissazione alla fase orale, una grande abbuffata di sentimenti che, inevitabilmente, causerà un mal di pancia psichico, spirituale. Chi l’avrebbe mai detto che la terribile tragedia di Seneca potesse avere il passo leggero della protagonista, e potesse avere i profumi, gli aromi delle spezie, del rosmarino, o della salsiccia fritta, o di un ragù napoletano che deve “peppiare” per tutta l’ora della rappresentazione. Il monologo ha una sua coté gastronomica, e viene decisamente la voglia ed il desiderio di fare la scarpetta di questo lavoro, di gustare, boccone dopo boccone tutto il sugo manzoniano di questa storia. I fiori del male possono stare tranquillamente in un vaso di balcone, accanto ai gerani, e basterà ogni tanto bagnarli di quotidianità perché si confondano tranquillamente con tutti gli altri. Il male non è più solo banale, come racconta la Arendt.
Quello di Ruccello ha il sorriso della giovinezza, è indistinguibile dalla normalità, dall’abitudine, dal chiacchiericcio del quotidiano. E in questo lavoro ci sono i colori anche del melodramma, del disperato e sincero bisogno d’amore che fatalmente trova una sua prima naturale significato nel corpo, nella carne dove si esprime. Dove stanno i pensieri, i sentimenti, quale organo è preposto a contenerli, qual è il segreto dell’equazione umana, dov’è il quid che caratterizza ognuno di noi? Questa domanda viene pronunciata dalla protagonista con tutta l’urgenza esistenziale, portando nello sguardo la luce ideale di un bisturi a cui sfuggono decisamente quei 21 grammi di anima, che hanno il sapore sottile delle cose metafisiche. Una giovane donna ama il suo capo, il suo ragioniere che sembra sragionare felicemente ed approdare all’amore con lei. Tuttavia la passione può avere un gusto prosaico, magari l’odore dei resti del pesce messi a bollire per il gatto.

Ma il cuore della protagonista ha delle ragioni che il ragioniere non conosce, lui è l’oscuro oggetto del desiderio, ed è un’ossessione bunueliana. È davvero brava la Ceni a rendere quanto l’assurdo possa diventare normale, e quello che potrebbe orripilare, far sobbalzare il cuore, possa invece lasciare alla protagonista la regolarità dei battiti di un atleta, 60, non uno di più, non uno di meno. Con le parrucche colorate, con gli occhietti che si fessurizzano come quelli di un piccolo simpatico carnivoro, l’attrice ritrova tutto lo spirito di un enfant terrible, di una ninfa che gioca col suo Humbert, ed ha la certezza chiara, come quella di dover morire, citando Nabokov, che quel ragioniere sarà suo. E, a volte, la camera, indugiando sul suo viso, trova dei meravigliosi sovrappensieri, dei momenti in cui davvero non si sa più da quale “io” vengano i gesti e le battute.
L’attrice ha la vocalità da clarinetto vivace di un’orchestra del jazz dixieland, che corre veloce, con i polmoni di una ragazza in grado di lasciare indietro la vita con il fiato corto, e sembra salire un po’ più su, un po’ più avanti rispetto agli altri strumenti. I fonemi si succedono agili e rapidi come un fraseggio, come una serie di note che si impreziosiscono del legno d’ebano di questa pregiata laringe. Ma è nel fotogramma finale che scopriamo tutto l’abisso che nietzschianamente guarda nella protagonista, troviamo la presa di coscienza che possedere l’altro è come cercare di catturare l’etere, che l’identità, la sua in primis, sta da un’altra parte. Per scriverla alla Lacan, la protagonista non è dove pensa, ma in quel manque, in quel vuoto, in quell’assordante, muta, disperazione con cui non trovando e non trovandosi, trova tutta la metafisica, tremenda, presenza dell’assenza.

Se questo articolo è stato di vostro interesse, vi proponiamo la lettura degli altri che troverete nella sezione teatro e le altre recensioni presenti sul nostro sito. Non scordate inoltre di ascoltare il nostro podcast per approfondire la conoscenza del vasto mondo teatrale.